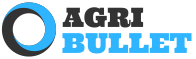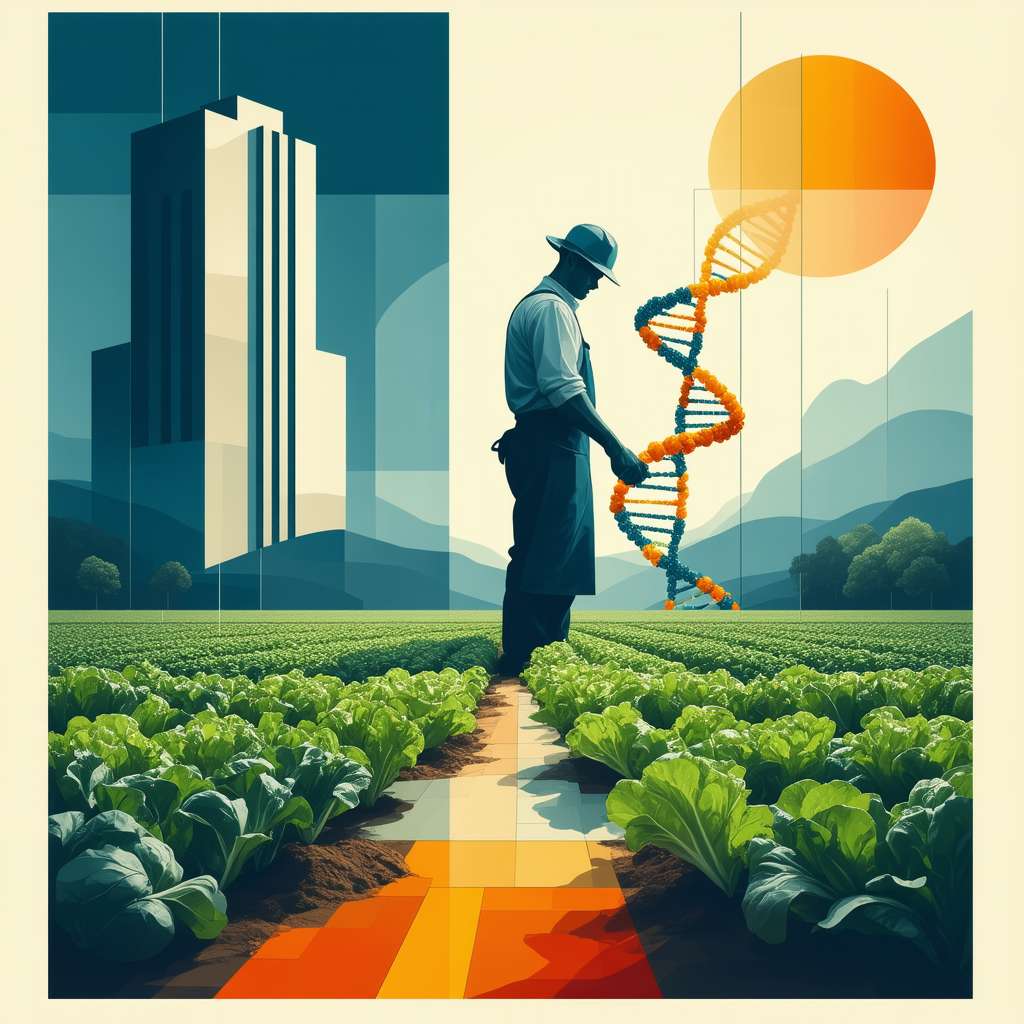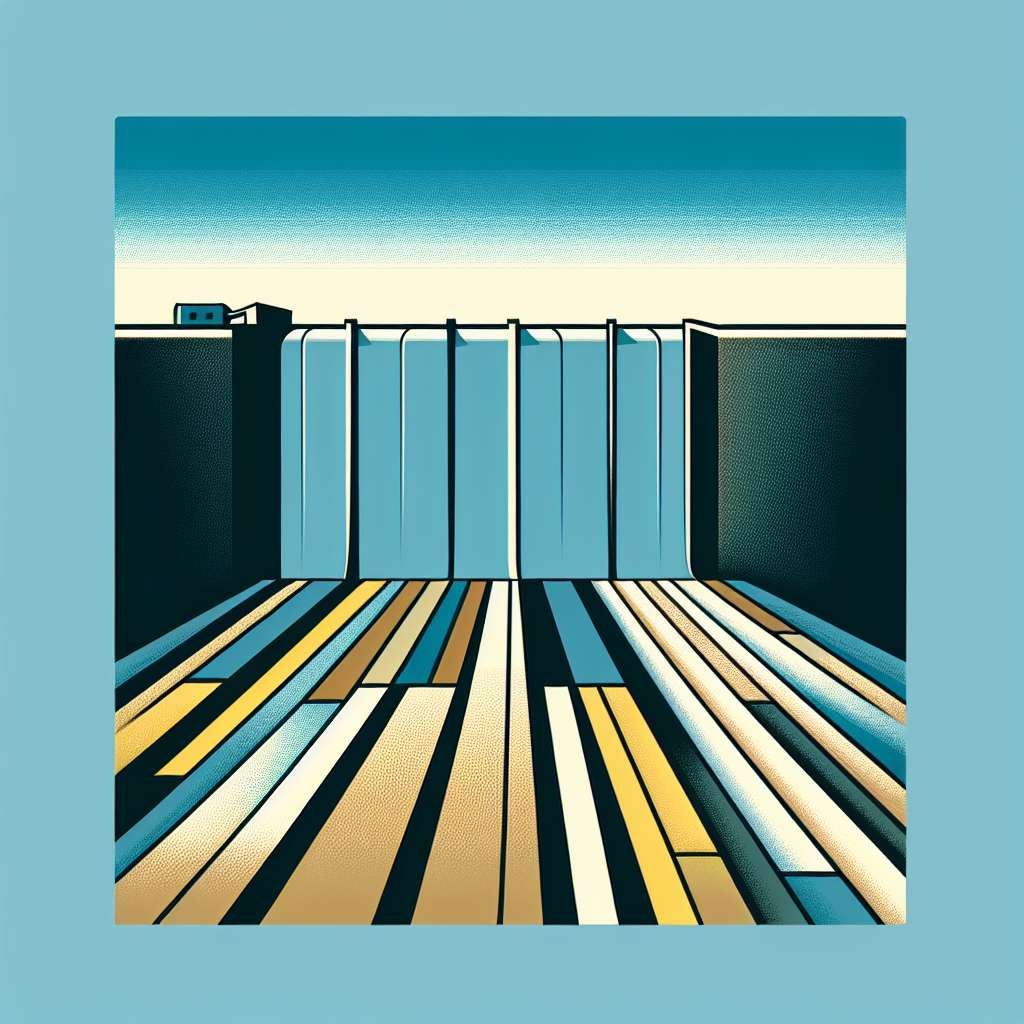E-Mail: [email protected]
- Quattro gruppi controllano oltre il 60% delle vendite globali di sementi protette.
- La fusione Dow-DuPont ha creato Corteva, valore stimato 130 miliardi di dollari.
- Nell'UE, il 75% del mercato del mais è in mano a 5 compagnie.
La questione del controllo delle sementi agricole, in particolare quelle relative all’insalata, si sta rivelando un tema di cruciale importanza nel panorama agroalimentare contemporaneo. La concentrazione del potere nelle mani di poche multinazionali solleva interrogativi significativi sulla sovranità alimentare, la biodiversità e il futuro dell’agricoltura stessa. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le dinamiche di questo complesso scenario, esaminando le strategie di controllo del mercato, l’impatto dei brevetti sulle sementi e le conseguenze per gli agricoltori e i consumatori.
La concentrazione del potere sementiero
Negli ultimi decenni, il settore delle sementi ha assistito a una progressiva concentrazione del potere economico e decisionale. Un numero ristretto di aziende multinazionali ha acquisito una posizione dominante nel mercato globale, controllando una quota significativa della produzione e della distribuzione delle sementi. Secondo alcune stime, solo quattro grandi gruppi – Bayer, Corteva, ChemChina e BASF – detengono oltre il 60% delle vendite globali di sementi protette da diritti di proprietà intellettuale. Questa concentrazione è il risultato di una serie di fusioni e acquisizioni che hanno portato alla creazione di colossi agroindustriali con un’influenza senza precedenti sul sistema alimentare mondiale.
Le strategie utilizzate da queste multinazionali per consolidare il loro potere sono molteplici e complesse. Oltre alle acquisizioni di aziende concorrenti, le grandi compagnie sementiere investono ingenti risorse nella ricerca e sviluppo di nuove varietà vegetali, che vengono poi protette da brevetti. Questi brevetti conferiscono alle aziende un diritto esclusivo sulla produzione e commercializzazione delle sementi, limitando l’accesso degli agricoltori alle risorse genetiche e ostacolando l’innovazione indipendente. Inoltre, le multinazionali stipulano accordi commerciali con distributori e rivenditori, creando una rete di controllo che si estende lungo tutta la filiera agroalimentare.
La concentrazione del potere sementiero ha implicazioni profonde per la sovranità alimentare. Quando poche aziende controllano la maggior parte delle sementi, gli agricoltori diventano dipendenti da queste compagnie per l’approvvigionamento delle sementi. Questa dipendenza può comportare un aumento dei costi di produzione, una riduzione della biodiversità e una perdita di autonomia per gli agricoltori, che si trovano a dover seguire le direttive delle multinazionali per quanto riguarda le varietà da coltivare e le pratiche agricole da adottare. In definitiva, la concentrazione del potere sementiero mette a rischio la capacità delle comunità locali di controllare il proprio sistema alimentare e di garantire un accesso equo e sostenibile al cibo.
La fusione tra Dow e DuPont, con un valore stimato di 130 miliardi di dollari, ha portato alla creazione di Corteva, un gigante nel settore. Parallelamente, l’acquisizione di Monsanto da parte di Bayer per 63 miliardi di dollari ha consolidato ulteriormente il potere nelle mani di poche entità. L’acquisto di Syngenta da parte di ChemChina per 43 miliardi di dollari ha permesso a quest’ultima di scalare le posizioni nella classifica delle vendite globali di sementi. Queste operazioni, che coinvolgono somme di denaro enormi, riflettono la dimensione degli interessi economici in gioco e la crescente importanza strategica del controllo delle sementi.
Tuttavia, la concentrazione del potere sementiero non è solo una questione economica, ma anche politica e sociale. Le decisioni prese dalle grandi aziende sementiere hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di persone in tutto il mondo, influenzando le loro abitudini alimentari, la loro salute e il loro accesso alle risorse naturali. È quindi fondamentale che la società civile, i governi e le organizzazioni internazionali si impegnino a promuovere un sistema alimentare più equo, sostenibile e democratico, in cui gli interessi delle comunità locali e dell’ambiente siano prioritari rispetto agli interessi delle multinazionali.
Il dibattito verte principalmente sulla proprietà intellettuale dei semi, i brevetti, concessi dall’European Patent Office (EPO) con sede a Monaco di Baviera. I brevetti, inizialmente pensati per i prodotti chimici e meccanici, oggi possono essere depositati anche su piante e animali. La campagna europea “No patents on seeds!” chiede l’effettiva applicazione della Direttiva europea 98/44/CE sui brevetti, contro la brevettabilità di varietà, piante e animali. Alcune organizzazioni non governative ritengono che, sotto le pressioni delle multinazionali, l’ufficio europeo abbia riconosciuto oltre 200 brevetti su specie vegetali riprodotte con metodi convenzionali di miglioramento genetico e circa 1.000 altre richieste siano in attesa di concessione.
Si stima che i brevetti valgano un giro d’affari di 1,5 miliardi di dollari (dato del 2013), e rischiano di diventare uno strumento per l’appropriazione indebita delle risorse agricole, mettendo a rischio la sovranità alimentare. Un esempio è il brevetto ottenuto da Syngenta sul peperone e sul suo utilizzo, che di fatto impedisce a chiunque di coltivare o raccogliere questo peperone, venderlo o usarlo per future selezioni.

L’impatto dei brevetti sulle sementi
I brevetti sulle sementi rappresentano uno dei principali strumenti attraverso cui le multinazionali esercitano il loro controllo sul mercato. Questi brevetti conferiscono alle aziende un diritto esclusivo sulla produzione e commercializzazione di determinate varietà vegetali, impedendo ad altri di utilizzare, vendere o scambiare le sementi protette senza l’autorizzazione del titolare del brevetto. L’impatto di questi brevetti è particolarmente significativo per gli agricoltori, che si trovano a dover affrontare una serie di conseguenze negative.
Innanzitutto, i brevetti sulle sementi limitano l’accesso degli agricoltori alle risorse genetiche. Quando una varietà vegetale è brevettata, gli agricoltori non possono più riprodurre le sementi da soli, ma devono acquistarle ogni anno dalle aziende titolari del brevetto. Questo crea una dipendenza economica che riduce l’autonomia degli agricoltori e aumenta i loro costi di produzione. Inoltre, i brevetti sulle sementi impediscono agli agricoltori di selezionare e migliorare le varietà vegetali in base alle proprie esigenze e alle condizioni locali, ostacolando l’innovazione e l’adattamento delle colture ai cambiamenti climatici.
In secondo luogo, i brevetti sulle sementi promuovono l’omogeneizzazione delle varietà vegetali. Le aziende titolari dei brevetti tendono a concentrarsi sulla produzione di un numero limitato di varietà ad alta resa, che vengono commercializzate su larga scala in tutto il mondo. Questo comporta una perdita di biodiversità, in quanto le varietà locali e tradizionali, spesso più resistenti alle malattie e adattabili alle condizioni ambientali, vengono abbandonate e sostituite dalle varietà brevettate. L’omogeneizzazione delle varietà vegetali rende il sistema agricolo più vulnerabile ai parassiti, alle malattie e ai cambiamenti climatici, mettendo a rischio la sicurezza alimentare.
In terzo luogo, i brevetti sulle sementi sollevano questioni etiche e sociali. Molte varietà vegetali brevettate sono derivate da risorse genetiche che sono state sviluppate e conservate per secoli dalle comunità locali. Le aziende multinazionali brevettano queste varietà senza riconoscere il contributo delle comunità locali e senza condividere i benefici economici derivanti dalla commercializzazione delle sementi. Questo solleva interrogativi sulla giustizia e l’equità del sistema dei brevetti, che sembra favorire gli interessi delle grandi aziende a scapito delle comunità locali e dell’interesse pubblico.
Nell’Unione Europea il 75% del mercato del mais è controllato dalle prime 5 compagnie del settore, così come l’86% del mercato della barbabietola da zucchero e il 95% di quello degli ortaggi (dati The Greens/Efa Group). Per l’alimentazione dipendiamo quasi esclusivamente da pochi colossi dell’agribusiness che si spartiscono il controllo della compravendita di cereali, frutta, ortaggi e di tutti i loro derivati. Anche se spesso non ce ne accorgiamo, la nostra scelta alimentare è strettamente limitata a poche varietà commestibili che si sono affermate sul mercato: quelle meno competitive da un punto di vista puramente economico sono state scartate e in molti casi sono scomparse definitivamente. Basti pensare che delle 80.000 specie vegetali commestibili oggi se ne coltivano solo 150, di cui 8 sono commercializzate in tutto il mondo (da: Slow Food).
Per contrastare gli effetti negativi dei brevetti sulle sementi, è necessario promuovere alternative che favoriscano l’accesso degli agricoltori alle risorse genetiche, la conservazione della biodiversità e l’innovazione indipendente. Alcune possibili soluzioni includono la creazione di banche di semi pubbliche, la promozione dello scambio di sementi tra agricoltori, il sostegno alla ricerca partecipativa e lo sviluppo di sistemi di certificazione alternativi che riconoscano il valore delle varietà locali e tradizionali. In definitiva, è necessario ripensare il sistema dei brevetti in modo da garantire che gli interessi delle comunità locali e dell’ambiente siano prioritari rispetto agli interessi delle grandi aziende.
Il “mercato nero” delle sementi
La crescente concentrazione del potere sementiero e l’impatto negativo dei brevetti sulle sementi hanno contribuito alla nascita di un “mercato nero” delle sementi. Questo mercato, che opera al di fuori dei canali legali, è alimentato dalla domanda di sementi non brevettate, varietà locali e tradizionali che sono state abbandonate dalle grandi aziende sementiere. Il “mercato nero” delle sementi rappresenta una risposta alla crescente dipendenza degli agricoltori dalle multinazionali e alla perdita di biodiversità che ne consegue.
Le sementi che circolano nel “mercato nero” possono provenire da diverse fonti. Alcune sono sementi conservate dagli agricoltori da generazioni, che vengono scambiate o vendute a livello locale. Altre sono sementi ottenute da banche di semi pubbliche o private, che vengono riprodotte e distribuite senza l’autorizzazione dei titolari dei brevetti. Altre ancora sono sementi importate illegalmente da paesi in cui le normative sui brevetti sono meno restrittive.
Il “mercato nero” delle sementi è un fenomeno difficile da quantificare, in quanto opera al di fuori dei canali ufficiali. Tuttavia, ci sono segnali che indicano che sta crescendo di importanza. Ad esempio, sempre più agricoltori si rivolgono a reti informali di scambio di sementi per procurarsi varietà locali e tradizionali che non sono disponibili nei negozi. Inoltre, alcune aziende agricole biologiche e biodinamiche producono e commercializzano sementi non brevettate per soddisfare la domanda di agricoltori che vogliono evitare la dipendenza dalle multinazionali.
Nonostante i benefici che può apportare in termini di conservazione della biodiversità e di autonomia degli agricoltori, il “mercato nero” delle sementi presenta anche dei rischi. Le sementi che circolano in questo mercato non sono sempre soggette a controlli di qualità, il che può comportare la diffusione di malattie e parassiti. Inoltre, l’acquisto di sementi illegali può comportare sanzioni legali per gli agricoltori.
Per affrontare il problema del “mercato nero” delle sementi, è necessario adottare un approccio equilibrato che tenga conto sia della necessità di proteggere la proprietà intellettuale delle aziende sementiere, sia della necessità di garantire l’accesso degli agricoltori alle risorse genetiche e la conservazione della biodiversità. Alcune possibili soluzioni includono la creazione di sistemi di certificazione per le sementi non brevettate, la promozione dello scambio di sementi tra agricoltori e il sostegno alla ricerca partecipativa per lo sviluppo di varietà vegetali adattate alle condizioni locali. La recente notizia del sequestro di 46 confezioni di sementi illegali in un’azienda agricola pratese, con sanzioni per 11.000 euro, sottolinea l’importanza dei controlli e della necessità di operare nel rispetto delle normative.
In conclusione, il “mercato nero” delle sementi è un sintomo di un sistema agroalimentare che presenta delle criticità. Per risolvere queste criticità, è necessario promuovere un approccio più equo, sostenibile e democratico alla gestione delle risorse genetiche, in cui gli interessi delle comunità locali e dell’ambiente siano prioritari rispetto agli interessi delle grandi aziende.
Verso un futuro agroalimentare sostenibile
La questione del controllo delle sementi si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione del sistema agroalimentare. Di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dalla crescente disuguaglianza sociale, è necessario ripensare il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo il cibo. Questo richiede un cambiamento di paradigma che metta al centro la sostenibilità, la resilienza e la giustizia sociale.
Un sistema agroalimentare sostenibile è un sistema che rispetta l’ambiente, protegge la biodiversità, garantisce un accesso equo al cibo per tutti e promuove la salute delle persone e degli ecosistemi. Questo sistema si basa su pratiche agricole che riducono l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, che conservano il suolo e l’acqua, che promuovono la diversità delle colture e che favoriscono la resilienza ai cambiamenti climatici. Inoltre, un sistema agroalimentare sostenibile valorizza le conoscenze e le pratiche tradizionali delle comunità locali e promuove la partecipazione democratica alla gestione delle risorse naturali.
Per realizzare questa visione di un futuro agroalimentare sostenibile, è necessario un impegno congiunto da parte di tutti gli attori della filiera, dagli agricoltori ai consumatori, dalle aziende alle istituzioni. Gli agricoltori devono adottare pratiche agricole sostenibili, come l’agricoltura biologica, l’agroecologia e la permacultura. I consumatori devono fare scelte consapevoli, privilegiando i prodotti locali, di stagione e provenienti da aziende che rispettano l’ambiente e i diritti dei lavoratori. Le aziende devono investire in innovazioni sostenibili e adottare modelli di business che creino valore per la società e per l’ambiente. Le istituzioni devono promuovere politiche che sostengano l’agricoltura sostenibile, che proteggano la biodiversità e che garantiscano un accesso equo al cibo per tutti.
La sfida è complessa, ma le opportunità sono enormi. Un sistema agroalimentare sostenibile può creare nuovi posti di lavoro, migliorare la salute delle persone, proteggere l’ambiente e rafforzare la resilienza delle comunità locali. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un cambiamento di mentalità che metta al centro il benessere collettivo e la responsabilità verso le generazioni future. Solo così potremo costruire un futuro in cui il cibo sia un bene comune, accessibile a tutti e rispettoso del nostro pianeta.
Un aspetto cruciale è sostenere le comunità scientifiche e agricole che custodiscono i semi democratici del progresso, recuperando il controllo delle riserve che possono essere conservate attivamente e migliorando e generando più diversità nei nostri campi.
E ora, un consiglio da amico. Se ti appassiona il mondo dell’agricoltura, ti suggerisco di approfondire la tecnica della rotazione delle colture. Questa pratica, apparentemente semplice, consiste nell’alternare diverse tipologie di piante sullo stesso terreno, apportando benefici significativi in termini di fertilità del suolo, controllo dei parassiti e riduzione della necessità di fertilizzanti chimici. Un’altra nozione interessante da esplorare è quella dell’agricoltura di precisione, che sfrutta le tecnologie digitali per ottimizzare l’uso delle risorse e massimizzare la resa delle colture, riducendo al contempo l’impatto ambientale.
Riflettere sul tema del controllo delle sementi ci porta inevitabilmente a interrogarci sul futuro del nostro sistema alimentare e sul ruolo che vogliamo giocare come consumatori e cittadini. Siamo disposti ad accettare un modello agroalimentare dominato da poche multinazionali, o vogliamo impegnarci per promuovere un sistema più equo, sostenibile e democratico? La risposta a questa domanda dipende da noi, dalle nostre scelte e dalle nostre azioni.
- Approfondimento sulla strategia di Bayer nel settore sementiero, in particolare sul mais.
- Comunicati stampa Corteva: accordo Simbiose, soluzione biologica agricoltura in Europa.
- Comunicato stampa ufficiale di Syngenta sulla strategia dopo l'acquisizione da ChemChina.
- Comunicato stampa sull'acquisizione da Bayer di asset nel settore sementiero.
- Comunicato sul completamento della cessione di DuPont a FMC, rilevante per la fusione.